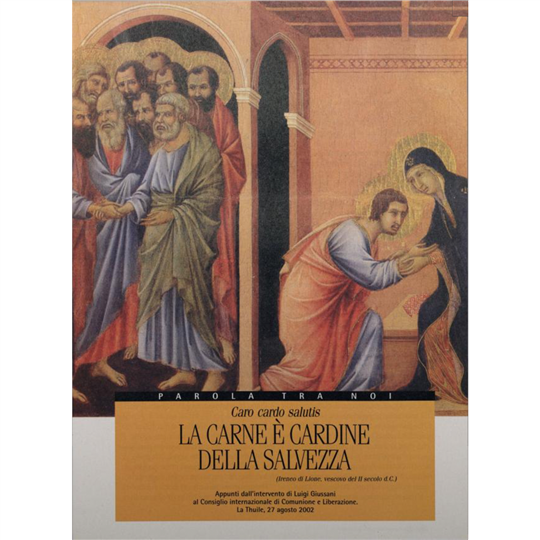
La carne è cardine della salvezza
Parola tra noiAppunti dall’intervento di Luigi Giussani al Consiglio internazionale di Comunione e Liberazione. La Thuile, 27 agosto 2002
Sono molto contento che il Signore, nella penombra di questi tempi, mi abbia messo in questo punto di luce, perché è proprio un punto di luce quello che voi avete riprodotto oggi ai nostri occhi e al nostro cuore. Ma vorrei riuscire a dire in particolare il perché di questo e che cosa si deve illuminare nel nostro modo di dire e di fare.
È una questione di parole? Non è questione di nessuna parola! Perché una parola diventa oggetto di discussione quando è proposta, quando l’incontro con questa parola è l’incontro con una cosa che non è quella parola.
Io spero che il Signore lasci anche a me la gioia di potere quotidianamente sperimentare, più di prima, che cosa vogliano dire certe parole. Ma - adesso lo dico come sono capace di dirlo -, sentendovi parlare, sembra che il problema per noi sia una parola o un’altra parola, siano delle parole. Così ci metteremmo subito in raccordo con coloro, anche di altre religioni, per i quali la parola entra nella vita del mondo e della società, nella realtà psicologica di un animo, perché è una parola.
Forse - anzi, senza “forse” - la morte che si avvicina è, da questo punto di vista, una cosa intensamente provocatrice, intensamente capace, finalmente, di cambiare tutti i termini della questione.
Di che cosa si tratta? Se non si tratta di parole, se non si tratta di luci particolari, di che cosa si tratta? Si tratta di un avvenimento - come dice il titolo di un libro dei nostri (L’avvenimento cristiano, Bur, Milano 1993), tra quelli che io raccomanderei molto quest’anno di rileggere bene -.
È un avvenimento, si tratta di un avvenimento: una cosa che non c’era e c’è. È chiaro che non c’erano le parole cristiane, non c’erano e adesso ci sono; eppure io credo di non riuscire a dissolvere quella specie di filo che mi tiene “prigioniero” ancora. È un avvenimento!
L’avvenimento è una cosa assolutamente determinata da quello che è, e che non è uguale a niente: se è uguale a qualcosa che è già accaduto, non ha più il peso di se stesso.
È quasi più tranquillo dire: è una “cosa”. È vero che questo ci avvicina alle spalle della cosa, a sentirne il riverbero nel passato. Ma è una “cosa” che non ha l’uguale, non ha il simile, non nasce, come possibilità di raccordo per essere capita, da niente!
Per questo mi permetto di raccomandare anche l’esito che - nel cuore di ognuno di noi e nel cuore dell’esperienza che ci rende una cosa sola - ciò deve avere. Mi permetterei cioè di raccomandare, da subito, quest’anno, di partire, di percepire o di sentire, o di pregare Iddio che faccia capire che il cuore di questa “cosa”, il cuore di un avvenimento, non coincide con nulla di quanto abbiamo stabilito o sentito prima.
Era come da ragazzo, quando la mia povera mamma ci leggeva - leggeva a noi fratelli, cominciando da me, che ero il maggiore dei quattro - il libro Cuore: quei nomi mi sono rimasti molto impressi. Dagli Appennini alle Ande, per esempio, è diventato proverbiale, non solo per me, ma per tanti, toccati un po’ dal lembo di una civiltà diversa da quella vissuta dagli altri. Ma dire che c’è stato un Hitler, c’è stato uno Stalin, dire che c’è un Bush, è dire una cosa completamente diversa che nominare l’esistenza di una persona. Una persona, quello che uno è, è una “cosa” senza nessun paragone, infinitamente, infinitamente diversa e più profonda di come si sentiva quella “cosa” prima di scoprirla come avvenimento.
Forse mi spiego male, perché non intendevo farvi un discorso; però mi è venuta la necessità di dirvi - perché la nostra posizione non sia mai una “condiscendenza” scontata a ciò che ci fa penetrare nel cuore dell’eterno - che non si tratta di cambiare il vocabolario, neanche di cambiare l’io: di fronte a quello che è successo (avvenimento), ogni paragone con cose che ci siano successe svaluta la questione.
Io vi prego dunque di dare principale spunto meditativo, da subito, a quello che il Signore mi ha fatto dire a Rimini (ché l’ultimo pensiero era a quel che dovevo dire), e non solo per la scelta di rendere contenuto particolare della nostra convivenza l’Inno di Dante alla Vergine, che porta su di sé, dentro di sé, il versetto più bello di tutta la letteratura mondiale (e non è affatto necessario che i nostri migliori lettori o - come dire? - “calcolatori di parole”, cioè i giornalisti, lo riconoscano); io vi prego di considerare come prima cosa quest’anno, come primo passo, prima parola su cui porre un piede, il nostro piede per poter avanzare, e come applicazione di quello che mi sono permesso di dire stamattina, le parole che il Signore mi ha suggerito a Rimini, non solo e non tanto per la bellezza della poesia di Dante, ma per una cosa come più “oscura”. Teoricamente, siamo tutti pronti a dire: l’importante sono queste tre parole: “fede, speranza e carità” - fede, speranza e carità! -. Ma è quando poi uno, fatta una certa strada, è toccato dentro - è come il sibilo di un sasso, di un sasso misterioso -, che capisce e dice: fede, speranza e carità.
Fede, speranza e carità. La cosa rimane ancora intatta nel suo limite: non sono le parole “fede, speranza e carità”, se non in quanto fede, speranza e carità sono le tre parole in cui tutto l’avvenimento c’è, afferrato e ben “impositato”.
In particolare, vi prego di sottolineare l’aspetto di questo avvenimento che traduce, che pretende di salvare con sicurezza, la natura eccezionale di quel che esso è, del rapporto con la realtà, con l’essere di cui noi siamo fatti, di cui siamo resi partecipi: è la parola “speranza”.
La fede scopre una cosa che c’è. La carità crea una cosa nuova nello spazio di Dio, nello spazio dell’eterno. La “speranza” è, delle tre parole, la più significativa, quella che s’avvicina di più al nostro abituale uso e consumo delle cose. La parola “speranza” è la più adeguata a farci sentire - anche se passa velocissimo, come il sibilo di un satellite - l’Essere: la parola “speranza” definisce per noi l’Essere.
Cesana: Grazie, don Gius!
don Giussani: Comunque, avevo pensato solo di salutarvi, con l’ammirazione e con lo stupore di uno che, in strada, vede un altro a cui accade qualche cosa: perché muore, perché vive, perché nasce, perché va a spasso coi figlioli alla domenica mattina (come faceva il mio papà, il mio povero papà, che mi conduceva a sentire le Messe solenni, cantate dai cori parrocchiali, nell’uno o nell’altro paese lombardo - sempre in Lombardia restavo).
Ma spero che almeno la morsa di qualcosa di strano ci possa essere resa interessante dal nostro angelo custode. Scusate se ho abusato del vostro tempo, ma volevo proprio far passare l’importanza dell’accenno che ho fatto.
Grazie a tutti! A che ora mangiate?
Cesana: All’una e mezza; adesso però c’è uno spuntino.
don Giussani: Ragazzi, fortunati voi!
Cesana: Buon appetito anche a te, don Gius.
don Giussani: Grazie, Cesana, ci vediamo presto.
Cesana: Sì, quando vengo a casa.
don Giussani: Già il fatto, qui, sostituisce la parola!





